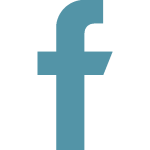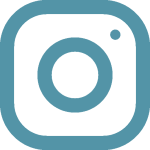Una giovane donna si suicida, dopo che il video di un suo rapporto sessuale viene diffuso da chi doveva tenerlo per sé, diventando virale.
Rabbia, vergogna, incredulità per le parodie e la totale mancanza di solidarietà e sdegno per questa gogna digitale hanno spezzato una vita forse già fragile. Facile dire ora che non avrebbe dovuto lasciarsi filmare, e soprattutto non avrebbe dovuto condividere il filmato con quei pochi che poi non hanno esitato renderla zimbello del web. Diciamo anche a margine che non sempre, e questa ne è prova lampante, i contenuti generati dall’utente sono una conquista e un motivo di orgoglio: possono diventare «prodotti ad alto inquinamento sociale», con una efficace espressione di Leonardo Becchetti. Ma al di là dell’amaro impasto di tristezza, indignazione per la violenza simbolica (che ha sempre effetti molto concreti) e del «certo che poteva evitare» è necessario cercare di imparare qualcosa da questa triste vicenda, che non fa onore a nessuno. Fermarci a pensare.
Thinking what we are doing, come invitava a fare Hannah Arendt, in tempi bui, per non soccombere al male intorno. Questo caso, nella sua tragica concretezza, ci può far riflettere su processi più generali, nei quali siamo immersi anche come parte attiva, ma spesso troppo poco consapevole.
Ne menziono tre, sui quali questa vicenda, e troppe altre che le somigliano, devono farci meditare.
Il primo è quello che tra gli studiosi viene definito il ‘collasso dei contesti’. È stata la Tv a dare inizio a una riconfigurazione della geografia della vita sociale, sganciando l’esperienza dal luogo, riscrivendo i modi della vicinanza e della lontananza, rendendo pubblico il privato. Con i social media questo processo si radicalizza: desideriamo raccontarci (l’atteggiamento di ‘estimità’ ed estroflessione che è il contrario dell’intimità) e pensiamo di essere in una stanza a parlare coi nostri amici, mentre invece siamo su un palcoscenico senza confini. Viviamo di fatto come in un palazzo di vetro, dove tutti vedono tutti. E questo crea un problema. Noi negoziamo infatti le nostre identità nelle relazioni con gli altri, in contesti diversi che richiedono una capacità di sintonizzarsi e assumere comportamenti appropriati; e questo implica la possibilità di rivelarci selettivamente ai diversi ‘pubblici’. Non è, si badi bene, una forma di ipocrisia, bensì di consapevolezza delle differenze. Non si sta in famiglia come sul lavoro, non ci si comporta a una festa come a un funerale.
Oggi la gestione consapevole del nascondere/mostrare è diventata molto più difficile.
E non è un caso che l’universo social stia privilegiando le applicazioni che consentono un’interazione più ‘privata’, più intima, più simile ai tradizionali contesti faccia a faccia: il tentativo è quello di suddividere di nuovo in stanze separate l’open space creato dai social media, di ripristinare la pluralità dei contesti. Ma siamo ancora lontani, e i rischi non mancano comunque. Con i social media, in ogni caso, il broadcasting del sé raggiunge una scala molto ampia, lasciando tracce permanenti e recuperabili nel tempo, la cui accessibilità è al di fuori del nostro controllo. Esserne consapevoli è fondamentale. E introduce il secondo punto cui prestare attenzione: quello della comunicazione social è un mix tra self-generated (prodotto dall’utente) e other-generated content (immagini ‘taggate’, commenti ai post etc.). Le audience per i contenuti creati e condivisi sono multiple, interconnesse e invisibili, potenzialmente illimitate.
E non controllabili. Ciò che noi produciamo non ci appartiene più e può essere usato contro di noi. L’illusione di essere ‘proprietari’ di ciò che abbiamo postato, delle nostre tracce nel web è davvero pericolosa, come si dimostra.
E infine, anche se le questioni sarebbero ancora molte, il rischio della perdita di realtà, che ci rende disumani.
La mediazione del dispositivo che ‘documenta per condividere’ rischia di anestetizzarci, se ci adeguiamo semplicemente alla logica della fattibilità. Dove tutto è possibile, niente esiste davvero, scriveva Benasayag.
Dove tutto è trasformabile in post e capitalizzabile in likes, nulla esiste davvero fuori di questa logica. Il ‘capitalismo delle emozioni’ ci porta a produrre, anche cinicamente, contenuti che possano diventare rapidamente virali, senza altro ordine di considerazioni se non quello quantitativo, in prospettiva autoreferenziale. Sì perché tutto questo, anche se non ci piace sentirlo dire, è figlio di un individualismo radicale dove niente conta più veramente, al di là di me. Dunque, non c’è solidarietà, compassione, rispetto che tenga. Nessuna ragione per mettere un limite alle nostre azioni. Perdita di realtà, anestesia, sé ‘quantificato’: non sono effetti necessari ma rischi in cui si cade senza accorgersene, se non si pensa a quel che si sta facendo. Se non si esce dalla logica di ciò che il dispositivo rende possibile, diventando puri esecutori di istruzioni scritte da altri, in preda al bisogno smodato di essere visti.
Ecco perché, per citare un altro caso su questa scia, si arriva fino a filmare, sghignazzando, l’amica violentata nel bagno della discoteca. Probabilmente, pensando a quanti rilanci avrà il video.
Perché del riconoscimento, della relazione il nostro io ha bisogno. E nella cornice dell’individualismo assoluto questo bisogno assume forme pervertite e disumane. È cronaca di questi giorni. Le donne, vittime, arrivano a farsi stolidamente complici dei carnefici. La tecnologia non libera affatto, se non ne capiamo il senso, ma anzi può essere piegata a forme subdole e sempre più perverse di umiliazione e violenza. Pensiamo a quel che stiamo facendo, a dove stiamo andando, a dove sta il senso. Per far sì che il dolore non sia inutile. Per non rendere vana questa triste morte. Che Tiziana, ora, riposi in pace.
Analisi di Chiara Giaccardi, fonte: Avvenire