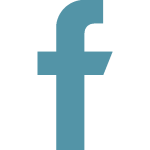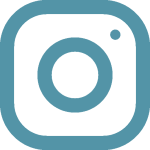La lezione de “La spada nella roccia”

In un vecchio cartone, il cuore dell’educazione
Di Lorenzo Ettorre per ilSussidiario
Una delle più belle avventure è rivedere insieme a figli o studenti i cartoni animati della propria infanzia.
Una delle avventure più entusiasmanti da vivere con i figli è rivedere insieme a loro i cartoni animati della propria infanzia, nel momento in cui un fenomeno incredibilmente eccezionale va a palesarsi ai nostri occhi normalmente resi già sapienti: in una storia conosciuta a menadito, lo scorgere in controluce percorsi, tracce, spunti e significati di cui per anni si è beatamente ignorata l’esistenza e che ad un certo punto, accendendosi, illuminano l’orizzonte sempre verde della comprensione.
Percorsi, tracce e significati, che in un misterioso e tenace legame tra ciò che eri e ciò che sei ti aiutano a svelare meglio dove affondano certi lati, certi gusti, certe preferenze di te stesso che si sono costruite insieme a quello che sei diventato oggi.
Questa avventura, credo comune ai più, per me si è palesata con “La Spada nella Roccia” – il grande classico Disney del 1963, l’ultimo ad essere prodotto interamente sotto la supervisione di Walt Disney – che è sempre stato il mio film Disney preferito e che oggi, alla luce di quanto detto, lo è ancor più. Non a caso, lo faccio vedere sempre a scuola al primo anno delle superiori.
Per una serie di motivi.
Innanzitutto, perché racconta splendidamente la dinamica che si innesca tra maestro e allievo.
Il maestro sa già il destino dell’allievo, cioè sa che ogni ragazzo è destinato a cose grandi nella vita: trasformare la propria esistenza in un capolavoro. Qualcosa di unico, di eterno, di propriamente “suo”. Un maestro che non sappia questo di ogni suo ragazzo è un cattivo maestro. Merlino lo sa, e sapendo qual è lo scopo di Semola calibra ogni azione per quella meta.
Nulla è a caso nel suo agire, tutto è funzionale allo scopo. Rispetto all’odierno vagabondare più o meno scoperto di tanti genitori e insegnanti mi sembra una prospettiva da rivalutare.
In secondo luogo, ne “La Spada nella Roccia” è descritto magnificamente cosa sia lo studio: non un freddo nozionismo da mandare a memoria ma un’esperienza affettiva ed emozionale di conoscenza e arricchimento.
Merlino non spiega a Semola come sono fatti i pesci, glieli fa “provare”; non spiega a Semola come sono fatti gli scoiattoli, glieli fa “vedere”, innescando in lui l’immedesimazione totale con l’oggetto del sapere, che sposta e crea punti di vista nuovi e arricchenti. L’apprendimento, d’altronde, è un avvenimento di conoscenza che trascina tutto di sé, ragione e affezione, come immergersi in un tramonto o nel volto dell’amata.
Non solo. Merlino accetta che può non essere lui il più adatto ad in-segnare, come nel caso della lezione sugli uccelli quando, con una ferita nell’orgoglio non indifferente, cede il posto al gufo Anacleto, evidentemente più esperto di lui (che ne sapeva solo in teoria) in materia di volo. D’altra parte, il vero maestro sa che l’allievo non è “roba” sua, e può non essere lui la miccia con la quale accendere il cuore di un ragazzo; per questo sa anche farsi da parte quando il bene del prossimo lo richieda. Merlino si arrabbia, brontola, si ammutolisce, ed è per noi una consolazione perché ci dice che l’insegnante (o il genitore) non è l’essere perfetto, non è l’incorruttibilmente puro – come a volte il potere ci ricatta di dover essere – ma è un poveraccio come gli altri che tuttavia sa quel che serve sapere, senza il quale tutto si trasformerebbe in dottrina: sa, cioè, dove deve andare il cuore per non morire. Il suo e quello di chi incontra.
Inoltre “La Spada nella Roccia” delinea magistralmente il paragone tra i due eterni prototipi di educazione: quella incentrata sul solo rigore e la sola disciplina – propria di sir Ettore, il padre adottivo di Semola (che pure vuol bene al ragazzo) – e quella animata dalla passione e dalla tensione al destino di Semola, che è propria invece di Merlino.
La prima non genera, è sterile, come si vede nel figlio naturale di sir Ettore, Caio, incapace di vivere se non nascosto nell’ombra ingombrante del padre, il quale a sua volta può solo scaraventargli addosso i propri ambiziosi e famelici piani; la seconda, invece, dà frutti, perché si pone al servizio del fanciullo senza la pretesa di conoscere già quale sia il bene più vero e più autentico per lui.
La sfida finale con Maga Magò è poi strepitosa: Merlino è meno scaltro, meno furbo, meno diabolico della perfida ma simpatica Magò, eppure vince a man bassa e di gran lunga il duello. Perché? Perché sa di più, conosce più cose e per questo sa andare più a fondo delle innumerevoli e variopinte sfaccettature che di volta in volta sa assumere la realtà.
Non ha bisogno di bluffare, gli basta sapere che esiste un germe invisibile ma potente per stendere l’ignara e vendicativa Magò.
Che lezione anche per i nostri ragazzi!
In classe faccio sempre questo esempio: se ho un velo di tristezza che mi avvolge il cuore, come spesso capita, un conto è se mi fermo a dire: “sto male” o “sono triste”, rimanendo in un giudizio vago e fumoso su ciò che mi sta capitando, altro conto è se arrivo a chiamare per nome quel malessere, in qualche modo “possedendolo”, e dire ad esempio: “sono malinconico”, “sono disilluso”, “sono frustrato”. Sono due mondi!
Solo se arrivo fin lì sono poi in grado di penetrare nei più labirintici rivoli dell’esser nostro, così da conoscermi meglio e meglio conoscere la realtà che mi circonda. Altrimenti posso solo subire ciò che mi capita. Quanto insondabile mistero può esserci nelle scatole cinesi di cui è fatto il nostro animo! In questo senso, dico sempre ai ragazzi: “conoscere i vocaboli non serve, comanda!” Come Merlino, che comandando, vince. Wittgenstein diceva: “i confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo”. E aveva ragione da vendere.
Torniamo allora a guardare i cartoni animati: sarà un modo, l’ennesimo, per riscoprirci figli dei nostri figli. E poter così, rigenerati, continuare a generare.