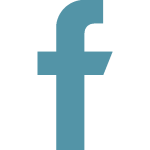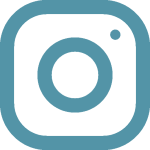Siamo chicchi di grano nel buio

Di Maria Teresa Abignente
Siamo affondati nelle viscere della terra, in uno spazio vuoto e oscuro. In questa nuova dimensione inedita stiamo però, paradossalmente, riscoprendo le radici della nostra umanità.
Appartengo ad una generazione che non ha conosciuto guerre, che non sa cosa significhi patire la fame, che non ha visto decimata la sua famiglia a causa di una pestilenza o di una carestia. Appartengo ad una parte di mondo che queste cose le ha viste solo in televisione, magari lasciandosi commuovere e un po’ intristire da quelle immagini così crudeli, ma pur sempre così lontane.
Il non aver vissuto nessuna di queste esperienze mi ha fatto crescere nella sicurezza e nella presunzione, come in una bolla di sapone, con la segreta convinzione che mai e poi mai mi sarebbe toccato qualcosa del genere.
E poi, sul finire dell’inverno è arrivato il virus che ha saputo spargere in tutto il mondo la paura, e soprattutto la cocente consapevolezza della vulnerabilità, di tutti. In un crescendo serrato, questo minuscolo esserino mi sta imponendo sacrifici e rinunce, mi chiede di fermarmi, di rientrare e stare in casa, mi chiede di scansare gli altri e non farmi toccare perché quel mostro infinitesimale può viaggiare su una carezza, su un bacio, su un sorriso ravvicinato, in una stretta di mano.
E allora capisco quella parte di umanità che deve ogni giorno fare i conti e morire per colpa di una stupida malattia, o che se ne deve stare rintanata in casa o in cantina per paura di qualche bomba; o quella parte di mondo che deve abitualmente rimanere in fila per prendere un secchio d’acqua. E quel mondo non è più così distante, è lo stesso mondo vicino.
Capisco che la natura ha un suo modo di ridimensionare la superbia dell’uomo e possiede una sua voce per avvisarlo e sgridarlo e fargli capire che no, non può continuare imperterrito a depredarla e sfruttarla; che essere il re del creato non vuol dire rubare, avvelenare, intossicare, ma “custodire e coltivare” nel rispetto gentile e nello scambio reciproco.
Capisco che l’uomo, ogni uomo, anche quello che ha avuto la fortuna come me di nascere in una piccola porzione di terra ricca e tranquilla, non ha in fondo nessuna certezza di immortalità. Creatura più che creatore, ogni essere umano è geneticamente vulnerabile e deve imparare ogni tanto a chinare il capo, perché non tutto può essere previsto, spiegato, controllato. E che la sua presunta onnipotenza è appunto un delirio, qualcosa che nasce da una percezione distorta della realtà, da una convinzione sbagliata di poter tutto sottomettere. E ancora mi accorgo che in questa terra dove mi consigliano di restare, che è la mia casa, affondano le mie radici: che la vita, quella vera, non sta fuori, ma dentro di me, nel pulsare ostinato del mio cuore, nella sua capacità di sopportare la solitudine, il silenzio e le contrarietà e nella sua possibilità di trasformarle e di renderle linfa. E che c’è un fuori raggiungibile sempre, basta avere occhi ripuliti e attenti.
Ritrovo il valore della pazienza, del saper rispettosamente attendere e preparare la festa, sognare gli abbracci e le carezze che verranno, con la stessa trepidazione di un primo appuntamento. Con lo stesso batticuore. Solo allora sentirò nel cuore l’indiscutibile certezza che, per assaporare quella festa, per gustare quella gioia, bisognava attraversare proprio questo deserto: la Pasqua non ci sussurra forse che ogni resurrezione deve passare attraverso una morte?
Ora siamo tutti chicchi di grano nel buio della terra.
E potremo essere una messe bellissima.