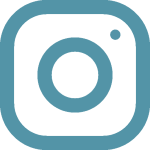Di Micol Forti
Vincent van Gogh ha speso la sua breve vita nella ricerca, intensa, vitale, disperata, della Verità e della Bellezza. Una Verità e una Bellezza che attraverso la pittura — il linguaggio che aveva scelto per capire e comunicare con il mondo — fossero capaci di accogliere le fragilità dell’uomo, di sostenerlo nei dubbi e negli errori, di lenire le sue sofferenze, di accompagnarlo nelle sue gioie.
Forse è per questo che, ancora oggi, dopo 130 anni, ci emoziona e ci commuove ricordare il giorno della sua morte avvenuta a Auvers-sur-Oise il 29 luglio del 1890. Una morte a volte sfiorata, quasi annunciata — van Gogh soffriva di patologie psichiche molto profonde — eppure ammantata di doloroso mistero, non essendo chiare le modalità e soprattutto il motivo scatenante che ha provocato quello sparo mentre si trovava tra i campi, facendo ciò che più amava: dipingere nell’aria e nella luce.
Vincent muore a soli trentasette anni. Da meno di dieci aveva iniziato a dipingere da professionista, realizzando centinaia di quadri.
Nato a Zundert, in Olanda, il 30 marzo 1853, prima di trovare la sua strada lavora nella casa d’arte Goupil & Co., nelle sedi di Bruxelles e Londra, città quest’ultima dove avrà modo di approfondire i suoi studi, in particolare quelli teologici. La conoscenza delle lingue — van Gogh parlava e scriveva perfettamente inglese, francese e tedesco, oltre l’olandese, sua lingua madre, e aveva una discreta padronanza del latino e del greco — gli permetterà di cibarsi voracemente di testi letterari, filosofici, poetici e, naturalmente, artistici. È l’arte, infatti, ad occupare il posto privilegiato dei suoi interessi: nonostante le ristrettezze economiche e le crescenti incertezze del suo stato di salute, van Gogh fu un appassionato viaggiatore, frequentatore di musei e raffinato conoscitore della storia dell’arte e degli artisti a lui contemporanei.
La sua fama planetaria fa sembrare noto questo personaggio complesso e tormentato, dotato di una profonda intelligenza, ma soprattutto di una umanità rara, ricca di sfumature e tenerezze, capace di accogliere e condividere specialmente con chi non aveva nulla, e allo stesso tempo afflitto dall’incapacità di trovare un posto protetto dove far sostare il suo cuore e il suo animo.
Tra gli aspetti meno noti, vi è sicuramente il fatto che van Gogh ha realizzato poche ma significative opere di carattere sacro. Tra queste, una delle ultime da lui eseguite, è conservata nella Collezione d’Arte Contemporanea dei Musei Vaticani: la Pietà, dipinta nel settembre del 1889.
La particolarità dei soggetti sacri realizzati da Vincent è che sono tutte opere d’après, ovvero copiate, rielaborate, derivate, da opere di altri autori. Perché van Gogh sceglie questo metodo così particolare per confrontarsi con la storia sacra, da lui profondamente conosciuta, studiata e amata? Perché per dipingere il corpo sofferente di Gesù, il sacrificio del Martirio, la tenerezza della Madre per il Figlio, è necessario aver visto, vissuto, capito le pieghe più oscure e più luminose del reale. Per raccontare il fatto sacro è necessario attraversare il mistero di cui si compone la vita e il Creato.
Gli artisti che hanno saputo fare ciò, per Vincent, sono pochi: Rembrandt, Manet, Delacroix, Millet. È a loro che guarda per potersi avvicinare a tematiche per lui cruciali.
La piccola, potente e intensa tela, conservata nei Musei Vaticani, rappresenta una Pietà che a sua volta riproduce un’opera di Eugène Delacroix del 1850. Un dipinto che van Gogh non vedrà mai in originale ma conosce solo grazie a una riproduzione, in bianco e nero e in controparte — ovvero con la composizione invertita destra/sinistra — che porta sempre con sé.
È infatti nella sua stanza quando, alla fine di agosto del 1889, l’artista, ricoverato nella clinica psichiatrica di Saint-Rémy, in Provenza, ha una violenta crisi nervosa. Gli infermieri che intervengono per calmarlo, rovesciano dell’olio e dei colori sulla litografia, rovinandola. Qualche giorno dopo van Gogh scrive al fratello Theo, pregandolo di acquistare una nuova litografia dell’opera, ma nell’attesa decide di copiarla a memoria, su una tela di piccolo formato.
La esegue per la sorella Willemien e in una lettera, a cui questo dipinto era unito, tenta di spiegarle l’importanza che ha per lui quella composizione. Lo fa con queste parole: «Quella di Delacroix è una Pietà, ossia un Cristo morto con la Mater Dolorosa. All’ingresso di una grotta giace inclinato, le mani protese in avanti sul fianco sinistro, il cadavere prostrato e la donna sta dietro. È una serata dopo la tempesta, e questa figura addolorata, vestita di blu — le vesti fluttuano al vento — si staglia contro un cielo blu in cui fluttuano nubi viola orlate d’oro. Anche lei, in un grande gesto disperato protende le braccia vuote in avanti, e si vedono le sue mani, belle forti mani da operaia. Con le vesti fluttuanti questa figura è quasi larga quanto alta. E poiché il viso del morto è nell’ombra, la testa pallida della donna si staglia chiara contro una nuvola — contrapposizione che fa sì che le due teste paiano un fiore scuro e un fiore chiaro, disposti appositamente per risaltare».
Vincent cerca di descrivere la verità di quella immagine e lo fa raccontando i colori che sono nella sua mente e sulla sua tavolozza: le «mani da operaia» della Madonna, il dolore che agita le sue vesti, il cielo tragicamente percorso di nubi. Lo colpisce il volto pallido della Madre che contrasta come un fiore chiaro con il volto in ombra del Figlio, nel quale Vincent inserisce il suo autoritratto. La pennellata è rapida, breve, potente. Come in una sinfonia musicale van Gogh costruisce il ritmo, l’armonia e il contrappunto per guidare il nostro sguardo nel misterioso cammino che unisce offerta e sofferenza, amore e dolore, morte e resurrezione.
Altri affascinanti risvolti riguardano questo dipinto, potentemente moderno, di cui l’artista realizza una seconda versione, inviata al fratello Theo e conservata al Museo van Gogh di Amsterdam. La tela è, infatti, un crocevia di storie, non tutte note allo stesso artista.
Van Gogh non sa che la composizione di Delacroix è tratta da un dipinto di Rubens, la Deposizione, conservato nella Cattedrale di Anversa. Rubens non è amato dal pittore olandese: nonostante il suo indiscusso e riconosciuto talento, lo ritiene troppo teatrale, superficiale forse, proprio nei dipinti a soggetto sacro, nei quali ogni espressione è esasperata fino a risultare falsa o inappropriata.
Ma un altro passaggio si cela dietro questa composizione: per il volto del Cristo morto Rubens si era ispirato a quello del Laocoonte, modello esemplare della rappresentazione pagana del dolore. Un capolavoro della statuaria classica da lui instancabilmente copiato, disegnato e interpretato nelle lunghe ore trascorse tra le collezioni archeologiche dei Palazzi Vaticani agli inizi del Seicento.
Un poetico dialogo a distanza, quello tra van Gogh e il Laocoonte, oggi entrambi conservati nelle Collezioni dei Musei del Papa; un dialogo che ci ricorda la forza delle immagini di sopravvivere oltre il loro tempo, di attivare contaminazioni e corrispondenze, di conservare le impronte della storia e di essere fertili e vitali nel futuro.
Nella sua Pietà van Gogh ha cercato di tradurre ed esprimere visivamente l’esperienza del sacrificio e della sofferenza ed è approdato sulla soglia della sua verità e la sua bellezza. Con la sua arte egli sa ancora oggi ricordarci come la forza della “pietà”, del sentimento di compassione e di compianto, sia dentro ognuno di noi e che ognuno di noi può donare e condividere con gli altri.
Fonte: osservatoreromano