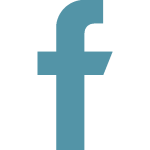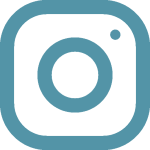Di Maria Laura Conte
Martire. Per don Roberto Malgesini Francesco ha usato la parola martire, che poi in molti hanno ripreso perché di rado una definizione è così su misura per una persona.
Aveva appena 51 anni e il 15 settembre alle 7 di mattina, mentre si chinava per caricare dei termos e le colazioni da distribuire ai senza tetto del quartiere, è stato pugnalato alle spalle da un disperato. Inerme, sembra che abbia cercato di fermare l’omicida, chiedendogli perdono per non essere stato in grado di aiutarlo come lui si aspettava.
Martire ha un suono che spedisce indietro nel tempo, a un passato remoto. Lo cerchi sul vocabolario e trovi come primo significato “testimone”, ma poi subito atterri sui primi cristiani perseguitati, che venivano ammazzati nei modi più atroci perché non accettavano di abiurare alla loro fede. E c’è il perché questo sostantivo è stato presto associato a loro.
La radice di martire è mer-, significa ricordarsi. In Sofocle, per esempio, l’eroe chiama gli dei come “martiri”, testimoni di certi fatti.
Il martire è testimone perché ha visto e ricorda. Non può scordare o rinunciare a quello che ha incontrato. Non solo: la radice è la stessa di merimna, che vuol dire cura, pensiero, sollecitudine. Da cui il verbo merimnào, sono in pena, mi do pensiero. Proprio come don Roberto si dava pensiero per quelli per cui preparava caffè caldo e pane all’alba.
Ma il risvolto interessante è che la vicenda di questo prete non è rubricabile sotto “fatto religioso”, e così scartabile in fretta perché riguarderebbe solo certe componenti della nostra società, considerate antimoderne. Un testimone così emana una forza attrattiva che raggiunge tutti, a prescindere da categorie di appartenenza, e risiede nella sua libertà. Lui era libero perché aveva chiaro “di chi” era, “per chi” viveva. Libero perché consumava il suo tempo per qualcuno.
Che tutti abbiamo bisogno di una ragione per vivere, lo sappiamo, ma tendiamo a trascurarlo finché qualcuno torna a ricordarcelo. A volte in modo drammatico, come per esempio quei giovanissimi che si imbarcavano anche da città benestanti europee per combattere per lo Stato islamico, sfuggire alla noia di una vita tra divano e youtube, e inseguire la promessa di una vita eroica, dedicata a una grande causa.
Il nulla non sazia, piuttosto divora.
Ma c’è una differenza sostanziale: se la ragione per cui dare la vita non ha il volto e la storia di persone in carne e ossa, vive, rischia di coincidere con un’idea astratta, una scatola vuota, da lasciar scivolare chi la persegue in una deriva violenta. Perché chi la pensa diversamente va eliminato.
Il martire-testimone di questi nostri anni iper-reali (surreale dopo l’esperienza della pandemia è un aggettivo scaduto) invece è così libero che può muoversi in mezzo agli ultimi, prendersi cura dei miseri, anche tra chi può diventare il suo assassino, senza essere frenato dalla paura della differenza, del rischio.
E un’opzione di vita così non è esclusiva per eroi. Anche questo don Roberto lo lascia intendere bene. È per gente così normale da essere invisibile.
Il nulla non sazia, piuttosto divora
C’è solo da superare una barriera, quella della fatica. Tutto di noi la vuole scansare, è la grande accantonata del tempo presente. Un abito fuori moda, chiuso in qualche baule in soffitta. E non è difficile capirne il motivo, come sa l’atleta dilettante: appena inizia l’allenamento, ogni fibra muscolare e ogni battito cardiaco scongiura: “Ma perché mi vuoi infliggere ancora questa fatica?”. Ma se il corpo si oppone, non di meno lo spirito, la volontà. Faticano a faticare. Ci vuole allenamento, ci vuole educazione. Dopo i primi chilometri, quando il fiato comincia a tenere e le gambe reggono l’andatura, si sperimenta quanto la fatica avvicini a traguardi prima ritenuti irraggiungibili (ed è una meraviglia).
Dove abbiamo smarrito l’educazione personale alla fatica? Si potrebbe aprire un dibattito vivace. Ma quanto potrebbe riconsegnarci, lo possiamo intuire dai gesti del martire di Como del 2020, che rubava tempo al sonno, ogni giorno, e si abbassava fino a terra per curare i piedi feriti di immigrati.
Chi, nell’accostare di striscio, da un articolo di giornale, questo don Roberto, non si sente sfiorare dal desiderio di vivere così? Può la fatica essere un’obiezione?
Fonte: Vita